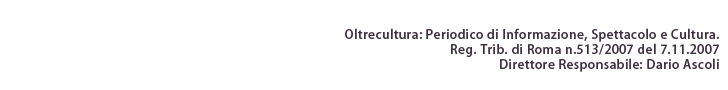«Cantare qui vuol dire entrare in un dialogo spirituale con un passato che ancora vive nelle strade di Napoli e ci ricorda quanto fosse importante la musica e l’arte vocale di questi artisti per il tessuto sociale e culturale della città»
«Cantare qui vuol dire entrare in un dialogo spirituale con un passato che ancora vive nelle strade di Napoli e ci ricorda quanto fosse importante la musica e l’arte vocale di questi artisti per il tessuto sociale e culturale della città»
A parlare è il grande controtenore, Premio Abbiati, Franco Fagioli, trionfatore nel recital «Velluti: Ultimo Castrato» , al Teatro di San Carlo, con l’Orchestra stabile diretta dal gesto enfatico, ma non sempre tempestivo del maestro George Petrou.
Argentino di origini italiane, Fagioli si è formato con il belcanto a Buenos Aires .
A Napoli l’artista ha anticipato il programma contenuto nell’album in uscita a febbraio «The last castrato. Arias for Velluti».
La scelta di un soggetto di genere maschile di cantare in un registro femminile non attiene all’orientamento sessuale, che è invece una libera opzione dell’individuo e che prescinde da timbro e tessitura vocali.
È pregiudizio diffuso, quanto di scarso fondamento, che i cantori evirati fossero in prevalenza impiegati in ruoli femminili in sostituzione di contralti, mezzosoprani e soprani donne, cui quel «Mulier taceat in Ecclesia» avrebbe precluso l’esibirsi, per un divieto, tra l’altro, limitato ai luoghi di culto.
La possibilità di convogliare un volume di fiato da capacità polmonare maschile adulta verso un organo vocale costretto, per mancata pubertà, a restare di dimensioni infantili, consentiva virtuosismi in termini di agilità e di durata dei suoni cui una cantante donna ben difficilmente avrebbe potuto ambire.
Ed ecco che non personaggi femminili amorosi, ma eroi guerrieri, sovrani, condottieri ricevevano la voce femminile di cantanti castrati, cui la mutilazione forzata, tra l’altro, assicurava una statura molto superiore alla media.
Tantissimi bambini delle classi meno fortunate venivano dai genitori sottoposti all’evirazione nella speranza di dar loro un avvenire da star del palcoscenico: naturalmente per molti sventurati restava la miseria in cui erano nati e la mutilazione, compensata solo dall’ opportunità di un’istruzione musicale e umanistica, che però spesso non bastava a sottrarli al reclutamento nel mercato del sesso.
Il recital, ha proposto molti cavalli di battaglia di Giovanni Battista Velluti (1780-1861), compositore e cantante italiano; si sono ascoltati brani di Rossini da «Aureliano in Palmira», di Mercadante da «Andronico» e dei meno noti Paolo Bonfichi, Giuseppe Nicolini e Francesco Morlacchi insieme con sinfonie di Mayr, Mantzaros e dello stesso Rossini.
Sopranista nato a Montolmo (Macerata), Velluti, anche grazie alla longevità artistica e biologica, ebbe modo di essere prescelto da Paisiello, Cimarosa, Rossini, per il quale fu primo interprete in «Aureliano in Palmira», opera destinata a fornire molti autoimprestiti, a cominciare proprio dalla sinfonia.
«Il mio progetto affonda le sue radici nel mio amore per il Belcanto, che si è sviluppato mentre ero studente al Teatro Colón di Buenos Aires – racconta Fagioli – un luogo con una solida tradizione operistica italiana».
Non da molti anni è consueto l’impiego di contraltisti artificiali, ovvero di artisti di sesso maschile, che con artifici tecnici, il falsetto, producessero voci femminili.
Fagioli è un controtenore dallo stile di canto “italiano”, rotondo e con una linea di canto con ampio legato e un vibrato che l’artista con gusto adotta nel repertorio del primo Ottocento cui l’ultima fatica discografica è dedicata.
Ci piace pensare che se nel XIX secolo vi fossero stati interpreti “integri” in grado di offrire interpretazioni quali Fagioli ha regalato al San Carlo, i compositori e il pubblico avrebbero individuato nuove pop star eredi dei castrati di un passato crudele verso i bambini più votati alla musica.
Quel che è verosimile è che proprio il sacrosanto abbandono di pratiche mutilanti abbia indotto ad adottare quella tecnica di falsetto che tanto si è ammirata nel cantante italo-argentino in una memorabile serata di musica, conclusa con un bis, ancora da «Andronico» di Mercadante.
Quando si potrà ascoltarlo nel repertorio napoletano settecentesco?
Fagioli, trionfatore al San Carlo nel recital «Velluti: Ultimo Castrato»
0
Share.