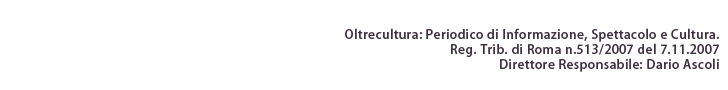Il recital tenuto da Danil Trifonov al San Carlo di Napoli il 6 febbraio scorso ad apertura del Festival pianistico 2025 ha offerto ad un teatro piacevolmente gremito un percorso musicale originale che ha alternato nelle due parti del programma strutture sonore ampie, architettoniamente costruite come, rispettivamente, la Sonata postuma in do diesis op.80 di P. I di Čajkovskij risalente ai suoi ultimi anni di studio a Pietroburgo e la Sonata op.26 di Samuel Barber, e brani brevi di ispirazione romantica come i valzer di Chopin tra cui l’interprete ha scelto una seria di sei o, nella seconda parte, i pezzi caratteristici che costituiscono la Suite da La bella addormentata di Čajkovskij nell’arrangiamento per pianoforte di Mikail Pletnev.
Il recital tenuto da Danil Trifonov al San Carlo di Napoli il 6 febbraio scorso ad apertura del Festival pianistico 2025 ha offerto ad un teatro piacevolmente gremito un percorso musicale originale che ha alternato nelle due parti del programma strutture sonore ampie, architettoniamente costruite come, rispettivamente, la Sonata postuma in do diesis op.80 di P. I di Čajkovskij risalente ai suoi ultimi anni di studio a Pietroburgo e la Sonata op.26 di Samuel Barber, e brani brevi di ispirazione romantica come i valzer di Chopin tra cui l’interprete ha scelto una seria di sei o, nella seconda parte, i pezzi caratteristici che costituiscono la Suite da La bella addormentata di Čajkovskij nell’arrangiamento per pianoforte di Mikail Pletnev.
Il modo di suonare dell’interprete russo di non immediata decifrabilità, ponendosi il musicista sulle prime con tratti apparentemente introversi, a tratti anche ruvidi favoriti dalla sonata čajkovskijana dal tono prevalentemente drammatico, cattura progressivamente l’ascoltatore nel suo mondo complesso, inquieto ed irrequieto, ricco di mille sfaccettature che alla fine comprendono dolcezza e affabilità, tratti cupi e gioia comunicativa, fantasia e rigore, forza accanto a sensibilità e poesia.
Il tutto tenuto insieme da un senso estetico fatto di misura e lucido dominio, sempre pensato, di questa vasta gamma espressiva che si snocciola nelle ben evidenziate linee del discorso sonoro e delle forme così come nella ricerca e resa timbrica e coloristica di tutte le potenzialità dello strumento a disposizione di cui si sviscerano ( contribuendo a ciò l’uso creativo del pedale), effetti e livelli dinamici soprendenti che spaziano dalla percussività a pianissimi quasi inudibili. Cosicché il programma prescelto si è rivelato quantomai idoneo a tale interessante viaggio musicale che ha tenuto in ogni momento desta l’attenzione. Della sonata in do diesis del compositore russo sono emersi i forti contrasti in un suonare appassionato quasi brusco nel primo movimento Allegro con fuoco, il cangiantismo armonico del più fluido e meditativo Andante prima di ritornare al ritmo incalzante dello scherzo che sfuma in un pianissimo introducente l’esplosione dell’Allegro vivo finale reso con piglio vigoroso.
Ha colpito per contrasto, la contenuta ed elegante esecuzione molto personale dei valzer di Chopin ( mi magg. opera postuma; op.70, n.2,;op.64 n.3 e n.1; op.34 n.2, infine quello mi minore, opera.post.) di cui si è esaltato in primis il volteggiare inarrestabile del tipico ritmo danzante e allo stesso tempo la mondanità salottiera in una trasfigurazione intimista fatta di malinconia, nostalgia, delicatezza.
Tutto era calcolato anche sui possibili slanci, sottovoce, profondo e leggero insieme, in un incedere serrato e continuo tra tinte e momenti svariati dati in una sorta di omogeneità, qualche giocosa libertà fungeva da citazione di un’epoca, rivelando comunque un costante pensiero sulla composizione. Sono emersi la grazia del primo, il legato del secondo valzer eseguito, la sottile inquietudine dell’op. 64 n.3, il moto perpetuo del brevissimo op.64 n.1, esaurito in un soffio, fino alla malinconia stilizzata dell’op.34 n.2 e al tempo Vivace quasi trascendente dell’ultimo valzer eseguito, che sussume la serie in un tutto organico.
Nella seconda parte, la Sonata op.26 in quattro movimenti dell’americano Samuel Barber non esente da suggesioni musicali tipicamente americane come le blu notes del secondo movimento Allegro vivace e leggero o alcune sonorità jazzistiche e folkloriche della tradizione statunitense dell’ Allegro con spirito conclusivo in forma di fuga, è stata percorsa con nitidezza sonora in un’estrema chiarezza delle sue linee strutturali rese percepibili e del suo linguaggio novecentesco che alterna soluzioni aperte e moderne a consuetudini sintattiche e compositive tardo romantiche attraverso sonorità ora cupe ora eteree o profonde come nell’Adagio mesto, in cui la musica stessa diventa un mondo parallelo. Poderosa e penetrante poi l’esecuzione della fuga conclusiva che ha confermato la straordinaria padronanza tecnica dell’interprete. Ad atmosfere diverse, nuovamente russe ha condotto infine l’esecuzione della suite dalla Bella addormentata di cui l’esecutore ha reso con approfondita ricerca timbrica la variopinta tavolozza di colori di ascendenza orchestrale.
Forse è il brano del programma più naturalmente in sintonia con la fantasia visionaria di questo pianista che ha tradotto la magia e la peculiarità sonora di ciascuno dei pezzi dell’intelligente versione pianistica di Pletnev dal balletto. Incanto sonoro, fluidità e disinvoltura di tutti i possibili passaggi della tecnica pianistica resi con massima pulizia e mai meccanici, ancora una volta una dinamica sfaccettata e sensibilissima a sevizio di una sconfinata varietà espressiva, hanno reso omaggio alla musica di Čajkovskij e ad un pianismo di altissimo livello. A conclusione, applausi entusiastici ripagati dal concertista con tre gradevoli bis che hanno fatto sognare ancora: il Valse de Santo Domingo di Rafael Bullumba Landestoy, Dolci sogni dall’album della gioventù di Čajkovskij e il Preludio n.10 dall’op.28 di Chopin.
Rosanna Di Giuseppe